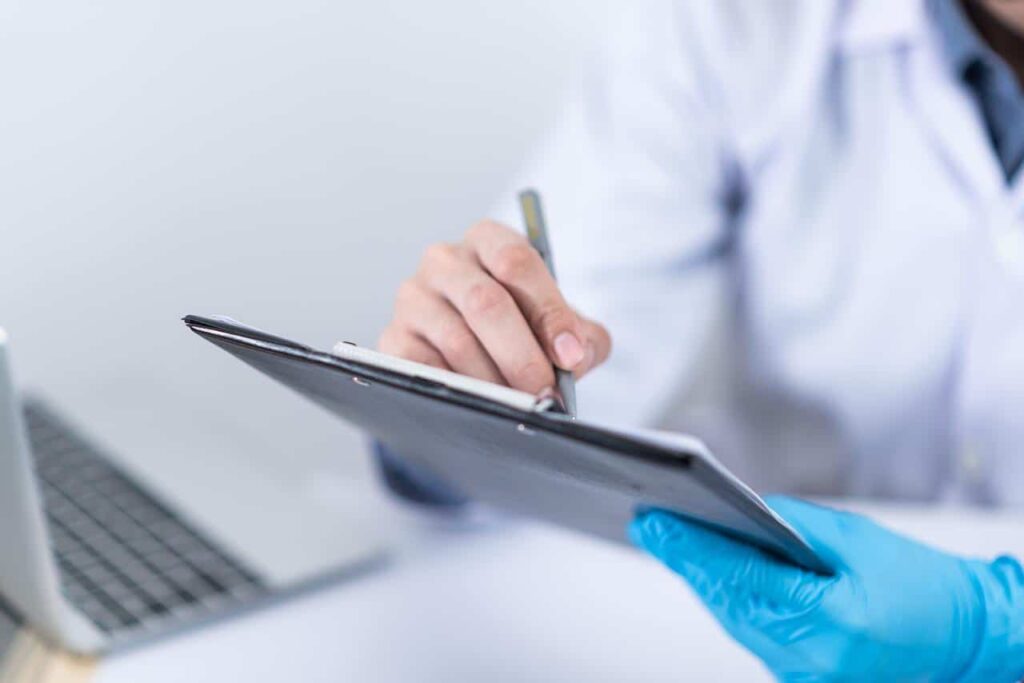
Con l’ordinanza n. 11731 del 2 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata in materia di licenziamento del dipendente affetto di tumore, precisando che l’applicazione del periodo di comporto ordinario al paziente oncologico che superi il numero massimo di assenze ai fini della conservazione del posto di lavoro costituisce discriminazione indiretta.
Il caso
Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo proposto da una società avverso la sentenza di primo grado che dichiarava nullo in quanto discriminatorio il licenziamento operato da questa in danno del lavoratore a causa del superamento del periodo ordinario di comporto, in quanto assente per 485 giorni tra il 20 marzo 2017 ed il 7 luglio 2019.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello, come il Tribunale, aveva ritenuto sussistente la discriminazione indiretta subita dal lavoratore in condizione di handicap dipendente dalla documentata patologia oncologica cronica dal 2010, in ragione dell’insufficienza dell’individuazione dello strumento appropriato e necessario di tutela delle condizioni di rischio del lavoratore svantaggiato, in forza della previsione di un arco temporale unico ed indifferenziato anche per i periodi di malattia imputabili alla disabilità.
Concludendo, la Corte territoriale aveva anche escluso la carenza dell’elemento soggettivo della società datrice, in considerazione della consapevolezza da parte di questa del fattore di handicap del lavoratore nonché del rischio di trattamenti discriminatori nel computo indifferenziato di tutte le assenze per malattia ai fini del comporto, non avendo previamente verificato la loro riconducibilità o meno alla patologia oncologica, pur essendone onerata.
Avverso tale pronuncia, la società proponeva ricorso per Cassazione mentre il lavoratore intimato non spiegava alcuna difesa.
L’Ordinanza n. 11731 del 2 maggio 2024
In particolare, la società datrice affidava il proprio ricorso a 4 motivi, esaminati congiuntamente dalla Corte.
Con il primo motivo di ricorso, si denunciava la violazione degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2000/78/CE, 1, 2 e 3 co. 3 bis, D. lgs. 216/2013, 7, D. lgs. 119/2011, 1218, c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto ritenuto il licenziamento intimato discriminatorio sull’erroneo presupposto dell’indifferenziato regime di comporto per tutti i lavoratori, normodotati e non, senza considerare la disciplina complessiva al riguardo, di previsione di un’aspettativa non retribuita, esaurito il periodo di comporto, a richiesta del lavoratore, di quattro mesi elevabile a sei, prorogabile di ulteriori sei mesi e il diritto di godimento, sempre a richiesta, di un congedo annuale di trenta giorni per cure non computabile nel periodo di comporto, per i lavoratori con invalidità superiore al 50%, come appunto il lavoratore de quo, che tuttavia non aveva proposto domande in tale senso.
Con il secondo motivo di ricorso, si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, lett. b) Direttiva 2000/78/CE, 3, comma 4, D. Lgs. 216/2003, per avere la Corte territoriale ritenuto mezzo “appropriato” e “necessario”, soltanto il trattamento differenziato del periodo di comporto per lavoratori normodotati e lavoratori con handicap, e non la totalità della disciplina di cui sopra nel suo complesso.
Con il terzo si denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti elementi costitutivi della condizione di handicap del lavoratore pur in difetto di allegazione della parte.
Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2000/78/CE, 1, 2 e 3 co 3 bis, D. lgs. 216/2013, 1175 e 1375, c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto incolpevole il comportamento di discriminazione indiretta nei confronti del dipendente il quale aveva giustificato le assenze con certificazioni mediche prove di qualsivoglia riferimento alla patologia oncologica.
La Corte, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarava gli stessi infondati.
In particolare, gli Ermellini, premesso che l’istituto del comporto sia da ricondursi nell’esigenza di individuazione di un “punto di equilibrio” tra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenza per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale, richiamando precedente giurisprudenza sul tema, hanno chiarito che costituisce discriminazione indirettal’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, poiché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili converte il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, in posizione di particolare svantaggio.
Sul punto assume rilievo fondamentale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, co. 3 bis, D. lgs. 216/2013, l’adozione, da parte del datore di lavoro, di accorgimenti organizzativi tali da contemperare l’interesse del lavoratore a mantenere un lavoro idoneo alle sue capacità psico-fisiche con quello del datore di lavoro ad usufruire dii una prestazione lavorativa utile all’impresa.
L’assunzione di detti accomodamenti ragionevoli presuppone l’allegazione e la prova, da parte del lavoratore, dell’esistenza di menomazioni fisiche, mentali o psichiche e la traduzione di tali limitazioni in ostacoli alla partecipazione alla vita professionale sulla scorta del principio di uguaglianza in relazione alla disciplina di riferimento.
Nondimeno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, D. lgs. 198/2006 nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria promossi dal lavoratore, non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall’articolo 19 della direttiva Ce 2006/54, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.
Questi principi, ritenuti validi anche nelle ipotesi di discriminazione indiretta nonché con riguardo alla consapevolezza del datore di lavoro in ordine all’handicap di salute del dipendente, conducevano il Supremo Consesso a confermare anche la statuizione circa l’esclusione della carenza dell’elemento soggettivo in capo alla società datrice, la quale era a conoscenza della patologia dal 2010, come provato dal progressivo abbassamento di livello delle mansioni assegnate al lavoratore e la conseguente incidenza negativa sulla vita professionale del medesimo.
Sulla scorta di dette motivazioni, la Suprema Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso, confermando dunque la statuizione della Corte di merito che condannava la società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel frattempo maturati.
La massima
L’articolo 40 del decreto legislativo 198/2006, nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parità, non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall’articolo 19 della direttiva Ce 2006/54, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.
avv. Alessandro Romano
per maggiori info
www.avvocatoalessandroromano.it






